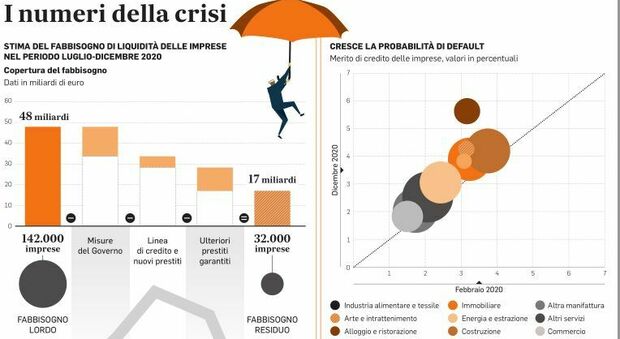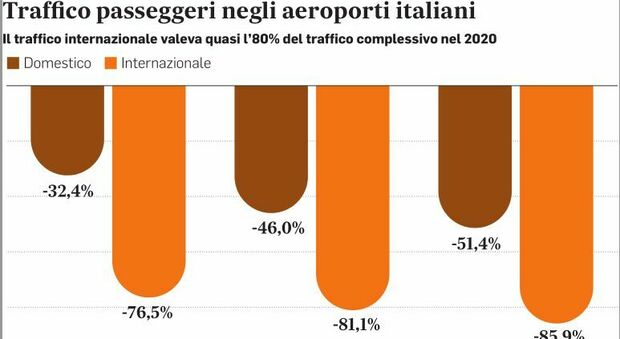Stephan Boujnah, 56 anni, ceo di Euronext dal 2015, ci parla dal suo ufficio tutto vetri a La Défense, nel cuore di Parigi. Conosce bene l’Italia, fin da quando da ragazzo visitava Pompei ed Ercolano sognando di fare l’archeologo. Il latino lo ha imparato allora. Poi la vita gli ha aperto altre strade. Ma ancora oggi si emoziona quando parla del Museo Archeologico di Napoli. Vuole tornare in Italia.
E le occasioni non gli mancheranno ora che ha acquistato Borsa Italiana dal gruppo Lse per 4,3 miliardi.

Boujnah, che cosa cambia per Euronext l’ingresso in Borsa Italiana?
«Cambia molte cose. Detta in breve, saremo leader fra i mercati dei capitali in Europa continentale. E Borsa Italiana, quale maggior contributore in termini di ricavi, avrà un grande merito, visto che almeno un terzo del fatturato verrà da lì».
Come pensa di garantire gli interessi del nostro Paese?
«L’Italia avrà un ruolo di primo piano ad ogni livello della governance, della gestione, della supervisione e dell’operatività. Cdp e Intesa Sanpaolo saranno azionisti di riferimento di lungo termine, impensabile che non abbiano una rappresentanza adeguata. Insieme a loro sarà più facile accelerare la creazione dell’Unione dei Mercati dei capitali in Europa».
Abbiamo capito che Borsa Italiana è strategica per Euronext. Ma ci spiega anche come Euronext sarà strategica per Borsa Italiana?
«Il nostro motto è “uniti nella diversità”: all’interno di Euronext ogni infrastruttura di mercato nazionale mantiene la propria identità e sviluppa appieno il proprio potenziale. Per il London stock exchange, Milano era diventata periferica: per Euronext lo sviluppo delle attività di Borsa Italiana sarà la massima priorità».
Lei dice che Milano era diventata marginale per Londra, ma nel board di Lse sedevano due italiani. Le richiedo: quanto peserà l’Italia nella governance di Euronext?
«Il nostro è un modello di governance federativa. Lo abbiamo definito 25 anni fa per integrare i mercati di Francia, Belgio, Portogallo, e poi lo abbiamo esteso ad Irlanda e Norvegia. Funziona, ed è pronto ad accogliere dalla porta principale anche l’Italia».
Sia più esplicito, quanti posti nel board ?
«Cdp, azionista principale, al pari della sorella francese Cdc avrà un posto nel supervisory board. Inoltre l’Italia avrà un membro indipendente del consiglio della business community. Questo consigliere verrà anche indicato come presidente di Euronext. Nel management board siederà il ceo di Borsa Italiana, insieme ai capi degli altri mercati. Infine, l’ad di Mts, che consideriamo una vera eccellenza, farà parte del management board esteso, che comprende i leader delle funzioni centrali».
Che cosa si devono aspettare le imprese italiane quotate e da quotare?
«La mission di Euronext è dare energia ai mercati europei dei capitali per finanziare l’economia reale. Euronext è il motore della crescita delle large cap e delle pmi, e questo è esattamente lo stesso obiettivo di Borsa Italiana. Questo completo allineamento offrirà una grande opportunità ai clienti attuali e futuri di Borsa Italiana: avranno accesso a un singolo pool di liquidità, attraverso un portafoglio ordini unico alimentato da un’unica piattaforma di trading».
Questo è un preambolo, entriamo nei dettagli.
«Tutte le società italiane quotate faranno parte di un listino molto più ampio, con una capitalizzazione di mercato aggregata pari a 4.400 miliardi, e del più grande pool di liquidità in Europa, con volumi giornalieri pari a 12 miliardi e il 25% del trading azionario in Europa. Ciò offrirà un enorme vantaggio alle blue chip e alle banche internazionali, ma soprattutto sarà un punto di svolta per le pmi italiane, per i broker e per gli asset manager locali».
Il titolo Euronext è sceso dopo l’annuncio su Borsa Italiana. Gli investitori temono abbiate pagato troppo. Per rifarvi, basteranno i 45 milioni all’anno di sinergie sui costi oppure avrete bisogno di spremere e tagliare di più? C’è chi teme che il business possa essere spostato da Milano a Parigi…
«Faremo esattamente il contrario. A partire dal cfo Giorgio Modica, che si sposterà a Milano. Per noi è un forte segnale di funzioni centrali che si spostano sull’Italia. Per quanto riguarda il prezzo, c’era un’altra offerta, è dunque l’esito di un’asta e quindi è un prezzo pieno. Il mercato critica, ma sottovaluta i numeri veri di Borsa Italiana, che sono migliori di quelli percepiti. Inoltre paghiamo il valore strategico di un’opportunità unica per Euronext».
Ma perché l’opportunità divenga anche redditizia, serviranno sinergie, quindi tagli. Non è quello che si fa quando una realtà aziendale si sposa con un’altra?
«Nessun taglio al business italiano, le sinergie saranno distribuite sull’intero gruppo. Ci sono alcune funzioni che Borsa Italiana svolge in maniera più efficiente rispetto ad altre nostre società. Viceversa, ci potranno essere funzioni più efficienti altrove. Sinergie da entrambi i lati».
Perché ritiene che l’Unione dei Mercati dei capitali sia tanto rilevante per il futuro dell’Europa?
«Perché permetterà all’economia dell’area di crescere in modo sostenibile e di diventare più competitiva e resiliente. La necessità di realizzare il mercato unico è diventata ancora più urgente nell’attuale contesto. Le imprese devono poter accedere ai capitali e gli investitori devono poter investire in progetti paneuropei, per uscire da questa crisi e per accelerare la transizione digitale e green. A mio avviso, nel mondo post-Brexit, l’Europa dovrebbe essere, e può essere, un continente di generatori di risorse finanziarie, con grandi e potenti banche europee, asset manager e infrastrutture di mercato europei, elementi necessari per far sì che l’Europa mantenga la sua sovranità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA